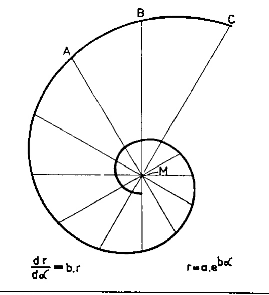Un saluto a Magri dall’aldiquà
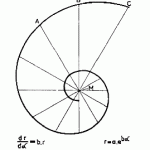 In questi giorni si è parlato tanto della morte di Lucio Magri, fondatore del Manifesto, ma più che della sua morte di COME ha scelto di morire. Nell’arco di poche ore si sono susseguiti i giudizi di politici dell’UDC già pronti a urlare che l’uomo non ha potere sulla propria vita e sulla propria morte, quelli dei radicali che han denunciato il fatto ch’egli sia dovuto “emigrare” in Svizzera per poterlo fare, altri hanno sospeso il giudizio finendo per concentrarsi sugli aspetti privati dell’accaduto. Sul Manifesto sono invece giunti i messaggi dolci e arrabbiati di chi l’ha conosciuto e ha condiviso con lui l’impegno politico, la vita privata, la costruzione del giornale. Il ritratto che si delinea da quegli scritti è quello di una persona convinta e determinata, una persona che a prescindere dalla sua carriera politica aveva degli ideali forti, sostenuti da una cultura vastissima (veramente invidiabile per molti della nostra generazione). C’è una frase particolarmente bella di Parlato che vale la pena di citare “intellettualmente generosissimo – una quantità di testi non firmati sono in realtà suoi, ma non gliene importava niente che gli venissero attribuiti, gli interessava che quelle idee circolassero – sembrava sgarbato a arrogante; pronto a riflettere sui suoi errori, non perdonava quelli degli altri, perché era oltremodo, fastidiosamente integralista.”
In questi giorni si è parlato tanto della morte di Lucio Magri, fondatore del Manifesto, ma più che della sua morte di COME ha scelto di morire. Nell’arco di poche ore si sono susseguiti i giudizi di politici dell’UDC già pronti a urlare che l’uomo non ha potere sulla propria vita e sulla propria morte, quelli dei radicali che han denunciato il fatto ch’egli sia dovuto “emigrare” in Svizzera per poterlo fare, altri hanno sospeso il giudizio finendo per concentrarsi sugli aspetti privati dell’accaduto. Sul Manifesto sono invece giunti i messaggi dolci e arrabbiati di chi l’ha conosciuto e ha condiviso con lui l’impegno politico, la vita privata, la costruzione del giornale. Il ritratto che si delinea da quegli scritti è quello di una persona convinta e determinata, una persona che a prescindere dalla sua carriera politica aveva degli ideali forti, sostenuti da una cultura vastissima (veramente invidiabile per molti della nostra generazione). C’è una frase particolarmente bella di Parlato che vale la pena di citare “intellettualmente generosissimo – una quantità di testi non firmati sono in realtà suoi, ma non gliene importava niente che gli venissero attribuiti, gli interessava che quelle idee circolassero – sembrava sgarbato a arrogante; pronto a riflettere sui suoi errori, non perdonava quelli degli altri, perché era oltremodo, fastidiosamente integralista.”
Molte sono anche le frasi rivolte alla sua depressione, a giustificare quello che può averlo spinto a decidere di morire in quel modo. Anche gli amici più intimi finiscono per cercare una spiegazione attribuendosi un ruolo, una responsabilità. La sua ex compagna Luciana Castellina conclude il suo ricordo con un “Non aveva più motivi che lo trattenessero e noi amici e compagni non siamo riusciti a dargliene di sufficienti.” Alla fine tutti, in un modo o nell’altro, cercano di razionalizzare ciò che molto semplicemente non si può far altro che ascoltare e accettare nonostante come ha scritto Sofri, siamo bravi a dire di rispettare la libertà dell’uomo e della sua morte ma quando coinvolge una persona cui vogliamo bene ci sembra improvvisamente ingiusto.
Dal momento che tanto è stata utilizzata la parola depressione ci tengo a sottolineare una cosa: le radici culturali del nostro paese solo parzialmente si sono staccate dal concetto che la malattia psichica sia diversa quella fisica. Nel profondo rimane radicata la convinzione che, infine, il malato psichico potrebbe fare qualcosa in più di quello afflitto da un male fisico. Una scoperta scientifica riguardo alla depressione penso possa insegnarci molto: i neuroni presenti nelle zone dell’encefalo che permettono di provare piacere, nei soggetti depressi hanno perso i prolungamenti cellulari che gli permettevano di comunicare tra loro, si nota proprio un’atrofia di queste cellule. Ci sono farmaci che aiutano a ripristinare queste connessioni, come determinate attività fisiche, determinati cibi. Ora pensate un secondo a un malato influenzale: gli si danno dei farmaci, pensate a una persona che si è slogata il piede, gli si consiglia attività fisica, pensate a un anemico, gli si consigliano determinati cibi. Allora perché il paziente depresso rimane un malato “solo parzialmente” ai nostri occhi e gli altri no? Qual è la differenza?
Perché molti di noi riconoscono come un diritto fondamentale quello di poter scegliere di “staccare la spina” in stato di coma irreversibile o in stadi avanzati di malattie neurodegenerative come quella che aveva colpito Welby e non lo riconoscono in un caso come quello di Magri? Perché molti riescono a immaginare la morte come epilogo di un carcinoma che non si è riusciti a guarire e non si riesce a immaginare la morte come epilogo di una depressione che non si è riusciti a curare?
Anche se questi esempi sono stupidi paradossi e non vogliono essere una semplice banalizzazione delle malattie psichiche come la depressione, vogliono solo significare che a volte non basta. A volte una persona depressa può seguire attentamente le cure e i consigli del medico che se ne occupa ma non guarire affatto. “Non si sceglie di morire come per una liberazione: questo è un eufemismo. Si sceglie, o ci si rassegna, a non poter più essere liberati.”
Io penso che il primo e irrinunciabile bisogno dell’uomo sia quello di essere libero. La libertà è partecipazione diceva Gaber, ma se prima di tutto non siamo partecipi della nostra vita non possiamo essere individui liberi. Qualcuno ci impone di alzarci il mattino? Qualcuno ci impone di curarci quando ci ammaliamo, di ricercare l’appagamento nelle cose che facciamo? Cioè, la vera domanda è: qualcuno POTREBBE MAI IMPORCELO? No. A meno ché non siamo già nelle mani di qualcuno, di un medico, per esempio, per quanto riguarda le persone in stato vegetativo. Ognuno di noi SCEGLIE di vivere e può scegliere di morire. Ci sembra inafferrabile il concetto dello SCEGLIERE DI MORIRE perché la violenza che siamo abituati a subire è quella del non poter scegliere ma contrarre una malattia, non poter scegliere ma essere vittime di un incidente. Ed essendo per noi così è normale che sia inimmaginabile RICERCARE la morte, desiderarla. Preferire la morte alla vita. Viene automatico pensare: che vita atroce dev’essere per preferire la morte? E forse è proprio qui che sbagliamo. Quando si dice: gli amici non hanno saputo dargli un motivo per non fargli compiere il gesto, la nipotina nemmeno. Avete mai provato a svegliarvi, un mattino, e sentirvi felici? Era la nipote? L’amico? Una frase detta da un amico? No, eravate voi, la vostra semplice e innata voglia di vivere. E quando uno non prova più quella sensazione, vivere diventa come la pena capitale per un condannato che non vuole morire.
“Il suicidio è una fondamentale libertà della persona. Chi è padrone della propria vita, come ogni umano lo è, può legittimamente e moralmente decidere di mettere la parola fine.”