Ripensare ( e ridare un senso) agli aiuti umanitari
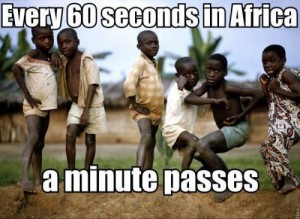 “Forse sono fortunata”, penso.
“Forse sono fortunata”, penso.
“Sono fortunata se i dubbi sul senso del mio lavoro, della mia professione, per la quale ho studiato, lottato, imparato, sofferto e fatto sacrifici, mi vengono solo ora, dopo dieci anni. In fondo, in Italia, gli amici e la famiglia mi guardano spesso con gli occhi spalancati, o con un’alzata di spalle rassegnata: “..beh, anche noi siamo insoddisfatti del nostro lavoro…anche a me non piace…anche io non sono d’accordo con quello che faccio o con le scelte del mio capo o della mia azienda.”
Come fare a spiegare loro che l’amaro che sento in bocca è diverso?
Perchè mi sono scelta un lavoro che sembrava, e sembra, ancora a molti (almeno fino a quando non arriveranno alla fine di questo articolo) l’incarnazione vivente dell’etica. Dei sogni. Delle utopie.
“Angelo”, “eroina”, “altruista”, “generosa”, “coraggiosa”……mi hanno chiamato, elogiandomi, in tanti modi in questi dieci anni.
Tanti, e soprattutto, in Italia.
Arrossivo, pensando tra me e me quanto questi aggettivi fossero lontani dalla realtà deludente e spaventosa che vedevo delinearsi missione dopo missione in Africa, in Medio Oriente, e negli altri paesi dove non ho lavorato ma dove ho sentito i racconti di amici e colleghi.
Facciamo un passo indietro.
Negli anni 80/90 gli aiuti umanitari facevano parte delle politiche estere dei paesi (Europa e Stati Uniti).
Questo voleva dire che erano parte di un piano governativo di relazioni estere. Esistevano anche gli aiuti indipendenti, ma la maggior parte, esclusi quelli finanziati dalle chiese (ad esempio i missionari), non potevano “resistere” alla comodità di veder assegnati progetti triennali o a volte anche più lunghi, con lauti finanziamenti. La cooperazione allo sviluppo (italiana e non solo) si è cosi trasformata in un pachiderma burocratico e altamente politicizzato, al pari, quasi, del sistema diplomatico: raccomandazioni, fondi pre-assegnati, alleanze politiche, eredità di posti di lavoro “alti” per conoscenza o parentela, disponibilità o meno di fondi a seconda dell’orientamento o dell’appartenenza politica. Tutto condito da tanta, tanta burocrazia, pagata con fondi pubblici.
Col passare degli anni il sistema italiano è stato portato al collasso da tagli e dalle manovre economiche, oltre che dal disinvestimento della politica governativa in tal senso, avendo stabilito che le relazioni di forza si fanno più con gli eserciti che con i progetti delle associazioni.
Così, ci si è gradualmente trasferiti nel cosiddetto “settore privato”.
Intanto, la figura del cooperante (o operatore umanitario) è radicalmente cambiata. Dai cooperanti cinquantenni, che prendevano contratti di tre, quattro anni, con stipendi medio alti e una sorta di “garanzia” (dovuta al fatto che si trattasse quasi di un lavoro “governativo”, sicuro e ben remunerato ), si è passati alla più totale precarizzazione della figura. Giovani, neo laureati, persone che necessitavano formazione e che invece, al di là delle proprie capacità, motivazioni o competenze si è iniziato a spedire sul terreno (spesso in contesti complessi: paesi in guerra, emergenze, in contesti sociali estremi, tra persone vulnerabili e realmente bisognose di aiuto). Capiamoci, non voglio associare il termine “precario” con il termine “impreparato”: pero’ è giusto evidenziare come, associato alle pratiche di precarizzazione, ci sia spesso la mancanza di formazione, oltre che di reclutamento in base all’esperienza. Nel lavoro sociale, così come nel lavoro medico e psicologico, questa pratica è particolarmente grave: immaginatevi un giovane, per quanto in gamba, ma senza alcuna esperienza di lavoro, che si trovi a gestire situazioni di violenza, di trauma, o semplicemente a fare fronte a contesti complessi, difficili, culturalmente e politicamente. Da solo e senza accompagnamento.
E’ vero che molte cose si imparano con l’esperienza, è vero che alcune cose non si imparano, si vivono e si affrontano e basta: ma ho sempre trovato una mancanza di “interesse” nei confronti dei risultati, e degli stessi beneficiari, persone che hanno dei bisogni (gravi)e necessitano delle risposte (rapide), e non hanno certo bisogno di essere la “nave scuola” di nessuno.
La terza e ultima fase di questo processo degenerativo, che si è aperta proprio negli ultimi anni ( soprattutto nelle grandi organizzazioni internazionali), è quella di un ritorno, dopo svariate figuracce, taglio ulteriore dei fondi per mancanza di credibilità e generale calo di popolarità delle ONLUS, a uno sbilanciamento verso il “tecnicismo” eccessivo degli operatori umanitari.
Tradotto in termini semplici, tra molti professionisti del settore umanitario oggi vige la mentalità per cui “non mi importa dove sono, faccio il mio lavoro senza guardarmi intorno nè chiedermi il perchè”. Giustificato inizialmente come un meccanismo di “coping” (reazione al dolore, allo shock della morte, al continuo essere sottoposti a situazioni disperate e di stress emotivo) in verità questo “disinteresse” degli operatori umanitari per le popolazioni, spesso per le stesse associazioni per le quali lavorano (nessuno sceglie quasi più per chi lavorare, come se un’associazione o un paese valesse l’altra) altro non si è rivelata che mancanza di etica del lavoro e di motivazione. Essere dei tecnici, bravi e competenti, non deve per forza voler dire essere disinteressati e non motivati, fare un lavoro come se fosse una catena di montaggio. l’aspetto umano, seppur non sufficiente da solo, resta una componente fondamentale del lavoro sociale-umanitario: perchè non è più così?
La “freddezza” (indifferenza) che spesso si ritrova, oggi, in alcuni operatori umanitari (non tutti), svela spesso anche le vere motivazioni personali legate alla scelta di vita dei cooperanti: volontà di mantenere uno status prestigioso (per l’estrema stima, mitizzazione di cui parlavo all’inizio dell’articolo), uno status economico, o semplicemente, cavalcare la possibilità di viaggiare, fuggire da casa propria, dai propri problemi o dalla noia quotidiana. La logica direbbe: “non mi interessa il perchè, purchè una persona faccia qualcosa di buono e di utile”. La mia risposta, opinione personale, è che la differenza la si fa con il COME, non tanto con il COSA: e potrei anche aggiungere che l’atteggiamento di molti operatori umanitari stranieri all’estero sta compromettendo l’intero settore umanitario mondiale (grazie a pessimi comportamenti, cattiva fama, enorme segregazione dalla realtà locale), già duramente provato dalla politica internazionale e dalla strumentalizzazione degli aiuti e delle missioni di pace.
Oggi, il settore umanitario non governativo è sul letto di morte: senza fondi, con poca, pochissima etica alla base del suo operato, molto spesso incapace di reagire ai dettami dei governi, dell’Europa, o del semplice marketing, che sta ormai pervadendo qualsiasi piccola attività, mirata solo alla ricerca di fondi.
Per capire la situazione, basterebbe farsi un giro a Goma (Repubblica Democratica del Congo), a Kabul (Afghniastan), ad Port Au Prince (Haiti), o in qualsiasi altro “ghetto” di operatori umanitari all’estero, dove la presenza delle ONG sta creando, e continua a creare, più problemi che benefici: almeno fino a quando il settore umanitario non verrà ripensato, ridefinito e ristrutturato, passando, a mio parere, per una fase di “tabula rasa” che ci permetta di ricominciare dalle vere basi.
Per approfondire:
Tag:
aiuti umanitari precarietà solidarietà


