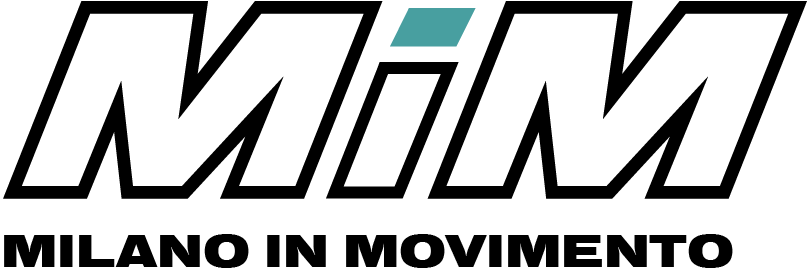La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza
Caso «unico» nel suo genere per l’abuso della decretazione d’urgenza, il Pacchetto Sicurezza del governo Meloni – trasferito tal quale dal ddl al decreto legge – è a rischio di incostituzionalità, nel metodo e nel merito. A sottoscriverlo, questa volta, è addirittura la Corte di Cassazione che dedica a questa specifica novità normativa – non proprio as usual – un apposito report. «La prassi parlamentare annovera due soli precedenti di trasposizione dei contenuti di un progetto di legge in discussione in Parlamento in un decreto-legge, a suo tempo in effetti censurati dalla dottrina costituzionalistica e, in ogni caso, nessuno dei due riguardava la materia penale», scrive il Servizio penale dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte Suprema nella relazione 33 pubblicata il 23 giugno 2025.
In 129 pagine mette a fuoco anche tutti i profili problematici e le manifeste criticità (qualcuna in più di quelle già molte volte segnalate) dell’«eterogeneo» contenuto dei 38 articoli del provvedimento governativo in vigore dal 12 aprile 2025. Pur dal carattere non vincolante, la relazione della Cassazione potrebbe costituire una solida base per eventuali ricorsi in Corte Costituzionale.
Citando le numerose associazioni di costituzionalisti, professori di diritto penale, magistrati (compresa l’Anm), giuspubblicisti (ad esempio, Articolo 21) e i tanti esperti auditi nelle commissioni parlamentari, nonché l’Osce e l’Alto commissario per i diritti umani dell’Onu, il Massimario riporta «severe perplessità anzitutto sulla (in)sussistenza dei presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tanto più che neppure il governo proponente si era mai avvalso della facoltà, prevista dall’art. 72 Cost. e dai regolamenti parlamentari, di chiedere l’esame con procedura d’urgenza di quel disegno di legge». «A ciò si aggiunge l’estrema disomogeneità dei contenuti», si legge nella relazione, che «avrebbe richiesto un esame ed un voto separato sulle singole questioni».
Mentre «la conversione in legge li riunisce “a bordo” di un unico articolo», in violazione della Costituzione (art. 72) laddove prevede l’analisi e il voto distinto per ciascun articolo. Il colpo di mano sul Parlamento potrà essere certificato, ricorda la Corte, in sede di «ricorso per conflitto di attribuzione da parte dei singoli parlamentari» (il primo è stato già proposto dal segretario di + Europa, Magi). Sul metodo, infine, la relazione ricorda che il decreto non è stato presentato alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso, come invece obbliga l’art. 77 della Carta. Mancando dunque i presupposti costituzionali della decretazione d’urgenza, fa notare la Corte Suprema, si potrebbe determinare «l’invalidità della legge di conversione».
Quanto al merito, la Cassazione mette in guardia sul «rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati» e sulle potenziali «discriminazioni e violazioni di diritti umani». Dalla disamina si evince l’estrema «incertezza applicativa» di alcune norme, per come sono state formulate le fattispecie di reato ma anche le aggravanti e gli aumenti di pena. in Molte parti del testo governativo i giudici riscontrano la possibile violazione dei principi costituzionali di «materialità», «precisione e determinatezza», «offensività», «uguaglianza», «autodeterminazione», «ragionevolezza» e «libertà di manifestazione del pensiero».
Per esempio, nel caso di alcune aggravanti o sospensioni condizionali della pena che vengono applicate solo se il reato viene commesso in un determinato luogo (stazioni o convogli), da una persona in un determinato status (l’essere detenuto), o in un determinato contesto («danneggiamento in occasione di manifestazioni», che evidenzia il rischio – spiega la Corte – di considerare «disvalore» la «contestazione e il dissenso»).
Discriminante è anche l’art. 15 che prevede l’esecuzione della pena negli Icam solo per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno (un giorno in più all’anagrafe del bimbo fa la differenza). Come lo è distinguere tra i pubblici ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nei reati di resistenza o violenza: «disparità di trattamento». Sempre in materia di ordine pubblico, il via libera a usare armi diverse da quelle d’ordinanza senza licenza non ha – attesta la relazione – alcun «plausibile ratio politico-criminale».
Nel caso delle rivolte in carcere e nei Cpr, «il precetto non fa alcun riferimento alla “legittimità” degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», oltre a violare il «principio di proporzionalità» nell’eventuale uso di resistenza passiva. E poi ancora: la norma che punisce le occupazioni abusive presenta «eccessiva indeterminatezza», è «di difficile configurabilità», e non prevede alcuna possibile «forma di impugnazione». Preoccupa particolarmente – «l’intervento più significativo e, per certi aspetti, più controverso» del dl – l’estensione dello scudo penale per gli 007 che creano o dirigono gruppi eversivi o terroristici «a fini preventivi».
E la «vera e propria fattispecie di volontà» che, in materia di terrorismo, sanziona «indistintamente comportamenti di carattere divulgativo» e attentati reali alla pubblica incolumità. Infine, last but not least, il divieto alla commercializzazione della cannabis (art. 18) «sembra impedire la libera circolazione di una merce all’interno dell’Ue in spregio al principio del mutuo riconoscimento e in rilevato difetto di esigenze imperative, non essendovi evidenze scientifiche che provino che le infiorescenze di canapa e i derivati di varietà di canapa con un contenuto di Thc inferiore allo 0,3% siano una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica».
di Eleonora Martini
da il Manifesto del 28 giugno 2025
Tag:
autoritarismo bocciatura carcere cassazione conflitto sociale controllo sociale ddl scurezza decreto sicurezza destra dissenso meloni opposizione orbanizzazione reati repressione stato di polizia