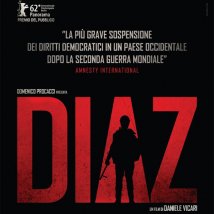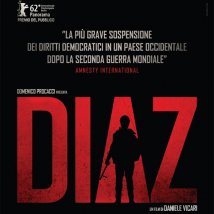Diaz, il film. L’opinione di Marco Rigamo – Global Project (4)
di Marco Rigamo
Le prime immagini scorrono all’indietro, come la memoria di chi ha attraversato quelle quattro giornate di fine luglio 2001. Sono i cocci in vetro di qualcosa che si è appena infranto sul marciapiede. Si ricompongono nella forma di una bottiglia di birra che rotea sopra una volante della polizia e termina tra le mani di un ragazzo. Vuota, innocua. Come vuoto e innocuo era quell’estintore impugnato il giorno precedente da Carlo Giuliani, ragazzo in canottiera, prima che una pallottola calibro 9 Parabellum lo centrasse in mezzo alla fronte da breve distanza. Il film è Diaz, di Daniele Vicari, prodotto da Fandangodi Domenico Procacci. La memoria è la mia. Di seguito le immagini sono di repertorio, ma subito vengono risucchiate dalla ricostruzione filmica di cosa accadde a Genova a partire dal tardo pomeriggio del 21 luglio. Attivisti e avvocati risentono della stanchezza di tre giorni di manifestazioni culminate in un omicidio. Nascono affetti e si saldano amicizie. Gli anziani nei carruggi brontolano, espropriati della loro Genova. Parlano in tedesco e in inglese ragazzi stranieri che hanno fatto della città una palestra di devastazione. Se ne vanno, missione compiuta. Ma in missione arriva invece da Roma un alto funzionario del ministero degli interni a organizzare un’operazione che ridia credibilità alle forze dell’ordine, riprese dai media di tutto il mondo unicamente impegnate a usare violenza feroce contro manifestanti inermi, quand’anche fossero donne, anziani o padri con il figlio al collo. C’è da “sgombrare un manufatto” dove si annidano i violenti, i black blok, i terroristi. “Ma c’abbiamo a foto de ‘sti terroristi?” chiede un sottufficiale al capo del reparto VII Celere. No, abbiamo l’articolo 41 del TULPS, il testo unico della pubblica sicurezza, che in flagranza di reato ci consente operazioni di polizia giudiziaria senza informarne il magistrato: il reato è la bottiglia vuota che non ha nemmeno sfiorato gli agenti. Che ci consente di entrare a tarda sera in 300, in tenuta antisommossa e perciò irriconoscibili, in un “manufatto”, una scuola adibita a dormitorio, massacrare scientificamente a colpi di tonfa e anfibio 93 persone inermi, dichiarare che sono stati trovati già feriti, creare falsi indizi di colpevolezza, arrestare 200 tra uomini e donne, trasferirne parte nella caserma di Bolzaneto, sottoporli a quattro giorni di torture assieme ad agenti di polizia penitenziaria e medici. Ci consente di fare quello che vogliamo e restare impuniti, di sputare loro addosso, di farli abbaiare come cani, di denudare e umiliare le ragazze. Questo racconta il film. Questo è quanto è accaduto. Anche se Vicari ci risparmia i piercing ai capezzoli strappati con le pinze e altri episodi di sadismo compiaciuto.
Ma confeziona un film compatto e duro, di passo veloce e ritmo serrato, perimetrato in una manciata di ore. Rapido nell’attraversare i caratteri e le tipologie delle diverse anime che diedero vita alla contestazione al G8 2001, supportata da più di 300 mila corpi. Attento ad attrezzare lo spettatore di strumenti per allargare l’orizzonte della comprensione di quale laboratorio di sperimentazione siano state quelle giornate. Una prova tecnica di guerra civile con quattro corpi di polizia trasformati in esercito da guerra interna sotto gli occhi dei Servizi di tutto il mondo. Mette in evidenza come l’input gestionale sia riferibile direttamente al potere esecutivo e non invece alla devianza di poche mele marce dei piani bassi. Restringe lo sguardo aggirando l’ipotetica necessità di fornire un’ informazione più ampia e didascalica sul contesto storico-politico, sulle ragioni e sulle molte identità degli attivisti e dei manifestanti, sulla militarizzazione a zone concentriche della città, sui dettagli della catena del comando e delle responsabilità politiche. Cambia i nomi, anche se non è difficile identificare il responsabile dell’Ucigos La Barbera, il comandante del VII Celere Canterini, il vicequestore Fournier e altri ancora (potrei citarli tutti, dal vicepresidente del Consiglio Fini blindato nella centrale operativa, all’agente scelto Nocera che accoltella lui stesso il proprio giubbotto). Racconta molto più di un elenco di nomi l’affettuosa telefonata al figlioletto fatta da un sottufficiale sorridente e reduce da un’operazione di macelleria messicana. Il cinismo programmatico e la follia solo apparente stanno in bella evidenza lì. Certo scontentando chi voleva un documentario esaustivo e magari un bel ritratto di sé nel documentario medesimo. In un formato di due ore decide invece per la velocità, rallentando solo nell’irruzione alla Diaz e nelle vessazioni a Bolzaneto. Sceglie di allargare lo sguardo su quei due unici scenari che non sono stati ampiamente documentati in un evento altrimenti connotato da un tasso di mediatizzazione senza precedenti.
Vicari non pretende di mettere in scena la verità, tutta la verità. Mettendone a fuoco solo una porzione, la meno raccontabile, non opera contestualmente la scelta di tacere sul resto. Porta la sua camera a mano dentro la Diaz come fosse uno delle migliaia di occhi elettronici – di professionisti, mediattivisti, dilettanti – che hanno documentato quei giorni. Ci mostra nei particolari quello che non abbiamo mai visto ma sempre immaginato. Il sangue sui pavimenti e sulle pareti, il rumore sordo dei manganelli e quello secco delle ossa che si spezzano. Il pianto, il terrore, la supplica inutile. L’ignoranza, il sadismo, l’incapacità di discernimento. Senza sconti, senza indulgenza, per un tempo infinito che schiaccia sulla poltrona e fa risalire la rabbia e chiude la gola. Sviluppa immagini di grande potenza e forza evocativa da un lato, di finzione narrativa incentivante voglia di sapere dall’altro, in grado tutte di risolversi in un pesante e incontestabile atto d’accusa. La mancanza di linearità, gli scarti temporali, l’occultamento delle identità, contribuiscono a edificare un’atmosfera di trappola e di sospensione del diritto, il lavoro di sottrazione ed elusione apre finestre ad approfondimenti possibili, che possono portare lontano. Magari a interrogarsi sul presente, visto che in più di dieci anni ben poco è cambiato, a partire dalla permanente assenza di un codice identificativo sulle divise delle polizie fino alla mancata introduzione nel nostro codice penale del reato di tortura, introdotto da una convenzione Onu del 1984. Non rileva il lavoro di indagine fatto dagli autori vagliando quintali di atti processuali e ascoltando numerosissime testimonianze su tutti i fronti quanto la capacità di penetrazione direttamente dentro le coscienze che le loro immagini mettono in campo. Non servono le informazioni sulla impunità dei pochissimi responsabili accertati organizzate nei titoli di coda, né le grottesche spiegazioni del presidente del Consiglio Berlusconi sulla cattura dei violenti coperti dai pacifisti nei telegiornali della domenica, quanto la percezione che è direttamente dal centro nevralgico del potere che il massacro della Diaz è stato concepito e organizzato in nome della ragione di Stato. Che è sempre lo stesso Stato stragista di quarant’anni fa raccontato da Marco Tullio Giordana. Che è sempre lo stesso Stato che abbiamo trovato in Val di Susa e in tutti i quadranti di lotta dei nostri territori. Lo Stato che consegna alle polizie la delega in bianco alla soluzione del conflitto sociale. Lo stesso che troveremo quando torneremo in piazza.
http://www.globalproject.info/it/produzioni/Diaz-Protagonista-e-lo-Stato/11276
Tag:
berlusconi Black Block bolzaneto canterini carlo giuliani daniele vicari diaz diazfilm domenico procacci fandango fini fournier G8 genova la barbera marco tullio giordana nocera roma ucigos