[DallaRete] Il cibo, il consumo, il conflitto. Dialogo tra Wolf Bukowski e Nicola Fiorita su #Slowfood, #Eataly ed #Expo2015
Questo editoriale coglie la questione del cibo e tutto ciò che le ruota attorno. Ormai da anni si parla ovunque di cibo: ricette nei telegiornali, nelle classifiche dei libri e nei reality show, nelle metafore dei politici. “Non c’è la crisi perché i ristoranti sono pieni”. “Nonostante la crisi abbiamo la cucina migliore del mondo”. “Dobbiamo spendere per il cibo invece che per i telefonini”. Patti della crostata per benedire riforme istituzionali. Attovagliamenti nei salotti cafonal. Alemanno che imbocca Bossi per siglare la pace della pajata del centrodestra. Renzi che ordina la pizza a domicilio a Palazzo Chigi. Conte che lascia la panchina della Juve perché la Campions League è come un ristorante da 100 euro al quale non ci si siede con pochi spicci. È tutto un magna magna. La fame e l’arretratezza dei piatti tradizionali trasloca nella vetrina ipermoderna, diventa anzi l’ultimo terreno di conquista dell’economia sulla società.
Sia chiaro: non abbiamo nessuna intenzione di diventare anoressici per combattere la bulimia che ci circonda. Ma è venuto il momento di mettere i piedi nel piatto. Attorno al comparto alimentare, alle sue dinamiche produttive e distributive come al suo immaginario e alla sua narrazione, si sta giocando una partita importantissima fatta al tempo stesso di deregulation e retorica del chilometro zero, svendita dei beni comuni, ricostruzione di identità locali e invenzione delle tradizioni. Wolf Bukowski ne La danza delle mozzarelle racconta di come Oscar Farinetti abbia recuperato un certo tipo di discorso “slow” che nasce a sinistra e nei cruciali Ottanta (anni di controrivoluzioni e di perversione del desiderio in consumo) per gettarlo in pasto da monopolista alle reti della grande distribuzione. Nicola Fiorita è un giurista, insegna all’Università della Calabria; è un narratore, membro del collettivo Lou Palanca che da poco ha sfornato Ti ho vista che ridevi, romanzo che ha molto a che fare con questi temi; è presidente di Slow Food Calabria. Li abbiamo messi a confronto per capire fino a che punto quel mondo è stato fagocitato. E allora cominciamo chiedendo loro: quanto è progredita quella che Wolf chiama “colonizzazione dello spazio semantico” della “sostenibilità” e del “territorio”? Che spazi di conflitto reale ci sono dentro questo recinto che se non fosse una parola ormai abusatissima definirei “ambivalente”? Fino a che punto la “narrazione” di Farinetti si è tramutata in “spam”, nel senso di ciarpame pubblicitario e in quello (originario) di junk food in scatola?

Wolf. Vorrei partire da un paio di recenti vicende bolognesi. In due diversi giorni di maggio i compagni e le compagne della rete di cucine popolari Eat the Rich hanno cercato di occupare spazi inutilizzati. Il primo è un ufficio vendita di appartamenti costosi nel quartiere popolare della Bolognina. L’elegante baracchino è chiuso da un anno e mezzo perché le vendite sono ferme. I cantieri stanno ripartendo solo adesso grazie a generosi finanziamenti del Comune, insomma con soldi pubblici. Il secondo è uno stabile di proprietà di Intesa Sanpaolo, una delle banche più tossiche immaginabili: banca di Expo e delle autostrade “connesse a Expo”, finanziatrice di Grandi Opere e istituto di riferimento di Confagricoltura, la sola organizzazione di settore che si schieri a favore degli Ogm. Ma Intesa Sanpaolo è anche partner ufficiale di Slow Food, Salone del Gusto, Terra Madre eccetera. Partner ufficiale e fagocitante, per rispondere alla prima domanda. Scopo delle occupazioni di Eat the Rich era, dichiaratamente, quello di creare cucine autogestite che rendessero “accessibile a tutt* un pasto buono, genuino e libero dallo sfruttamento del territorio e del lavoro” usando prodotti dell’agricoltura di prossimità e creando il nodo di una logistica alternativa per i prodotti che vengono da più lontano. Se ci limitiamo quindi alle parole, beh, queste sembrano effettivamente le stesse di Slow Food o dei Gas più innocui (quelli che si illudono di cambiare il capitalismo creando una nicchia di mercato “etico”), quando non addirittura quelle delle linee di prodotti “socialmente responsabili” della Grande Distribuzione Organizzata. Ma se queste parole sono pronunciate nel conflitto territoriale, nella lotta per l’agibilità sociale e politica delle città, la polarità del loro significato si definisce e punta decisa verso la trasformazione sociale. I poteri politici, istituzionali ed economici, che in questa fase storica vivono una convergenza opprimente, lo sanno benissimo, se ne accorgono subito. Sanno che “chilometro zero” detto dalla mensa popolare autogestita non significa lo stesso di “chilometro zero” esibito da un cartellino nell’ipermercato. Entrambe le occupazioni di cui ho raccontato vengono sgomberate in poche ore e i locali sono restituiti all’inutilità, al non-uso, all’essere mero totem del diritto di proprietà e di speculazione immobiliare. Ma dimostrano che la “decolonizzazione del campo semantico” si fa in strada, muovendosi tra i bisogni sociali di produttori e mangiatori di cibo.
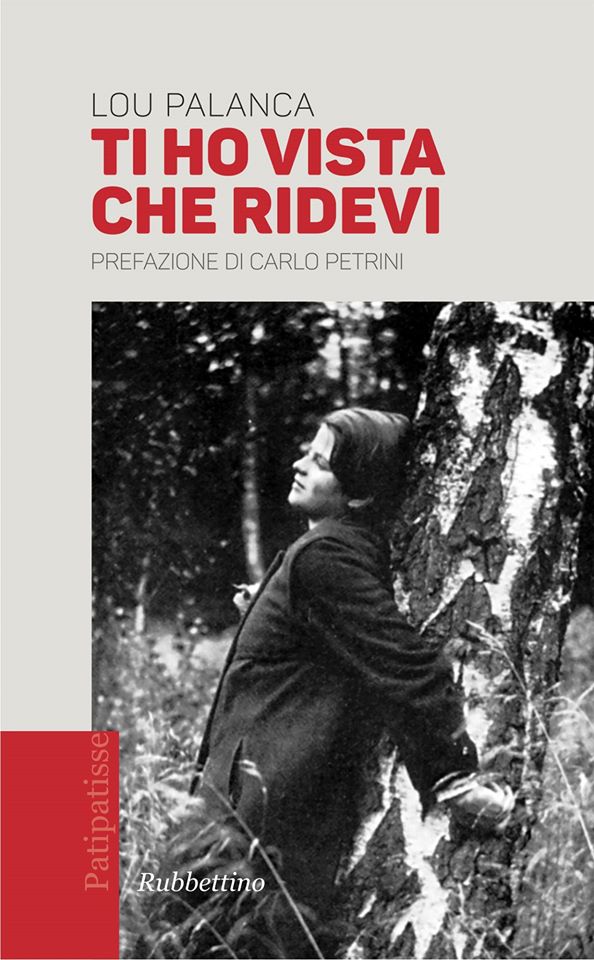
Nicola. Anche io penso proprio che si debbano mettere i piedi nel piatto. Per la verità c’è chi, come Slow Food, tenta di metterceli da 30 anni, quando il tema della produzione e del consumo alimentare non appartenevano certo alla riflessione pubblica, né di sinistra né di destra.
Non concordo affatto con l’idea che Farinetti o le multinazionali abbiano fagocitato (“sussunto”, mi pare ripeta spesso Wolf nel suo libro) per intero il programma e l’azione di Slow Food o di altri attori sociali di sinistra che operano in questo settore. Se guardiamo a Slow Food possiamo certamente chiederci quali cambiamenti abbia prodotto questo movimento e se ne ha prodotti, nella consapevolezza che la scala sulla quale dobbiamo collocarci è quella globale, perché il tema è globale e perché con tutto il rispetto per le lotte coraggiose dei lavoratori di questa o quella azienda non possiamo confrontarci sorvolando, ad esempio, sul fatto che il land grabbing sta espropriando per sempre i contadini di mezzo mondo della loro terra e del loro futuro.
Terra Madre, che Slow Food promuove dal 2004, non è altro che la più grande rete di contadini, allevatori, pescatori, artigiani, musicisti, cuochi che il mondo agricolo abbia mai conosciuto; il progetto 10.000 orti in Africa è un tentativo concreto di rispondere alla strategia neocolonizzatrice delle multinazionali dell’agricarburante che imperversano sempre di più in quel continente; la battaglia di Vandana Shiva e dei contadini indiani contro la Monsanto porta con sé il marchio della chiocciolina di Slow Food; l’università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (che pure potrebbe apparire l’apice di una visione radical-chic se la si osserva con pregiudizio) ambisce a costruire con le sue borse di studio una classe dirigente contadina nei paesi meno attrezzati.
Niente di tutto ciò starà mai negli scaffali di Eataly. Ciò non toglie che, a mio avviso, il rapporto con la grande distribuzione rappresenta il passaggio più delicato che Slow Food dovrà affrontare nei prossimi anni, perché la Gdo è una grande tentazione per la forza che genera e per le ricadute benefiche immediate che ha su progetti, produttori, piccole economie. Ma si tratta anche un enorme rischio per le ragioni che Wolf ben illustra nel suo lavoro.
Giuliano. Riprendo le parole di Nicola. In qualche modo, sembra dire, Slow Food porta avanti alcune delle rivendicazioni del movimento di Seattle e degli altermondialisti. Sappiamo che quel movimento era composto anche da grosse Ong, che abbiamo imparato a conoscere come soggetti attivi della globalizzazione, quasi istituzioni di nuovo tipo dentro la Costituzione mista che attraversa lo spazio planetario. Le Ong in altre parole costituirebbero le aspirazioni “democratiche” del mercato globale. Il parallelo regge?
Nicola. Non so se il parallelo regge e se riesco a comprenderne tutte le implicazioni. Posso solo dire che, a mio modestissimo avviso, un altro mondo è possibile – per restare in tema con le tue rievocazioni – solo se qualcuno prova a costruirlo. Allora, se il mondo del mercato globale non ci piace dobbiamo praticare altre strade, dobbiamo immaginare un mondo che non sia orientato dal e al mercato, nel quale certamente il mercato esiste ma non prevale sul bene comune, sulla salute pubblica, sul diritto di chi non c’è ancora o di chi non può alzare la voce o sventolare un portafoglio o magari scrivere un libro.
In ogni caso, devo aggiungere che Slow Food non si è mai pensata o rappresentata come una organizzazione non governativa. Piuttosto, ha costruito la sua storia sul principio dell’autonomia che in qualche modo è davvero la cifra di molti Slow Food attivi nei vari Paesi. Ogni Paese, in qualche modo, ‘è’ Slow Food a modo suo. Se dovessi isolare una caratteristica politica che differenzia Slow Food da molte Ong che fanno un lavoro egregio nel mondo, questa sarebbe probabilmente legata al tema del piacere. Slow Food è partita proprio dal piacere, dall’idea in qualche modo eretica che si può provocare un cambiamento anche attraverso il piacere. Ma cosa significa questo, per esempio, in un Paese del Sudamerica dove il mais ogm statunitense sta distruggendo le vite e i campi dei contadini? In questi paesi il piacere è legato all’idea di riconoscimento, di gratificazione e di valorizzazione di intere comunità che si vedono derise dall’avvento dell’agricoltura industriale e della gastronomia senza sapore e senza identità.
Slow Food ha costruito una rete di persone in carne e ossa che in ogni angolo del pianeta supportano le battaglie di contadini o di allevatori o di pescatori contro l’agricoltura industriale che mette a repentaglio non solo la biodiversità locale, ma, in alcuni casi, anche la possibilità stessa di continuare a vivere in quella determinata zona così come è stato possibile fino a quel momento. Quello che accade in questi luoghi non è certamente merito di Slow Food, ma la rete intessuta da questo movimento ha offerto sicuramente un’opportunità significativa per far riconoscere a queste comunità il senso della loro piccola-grande resistenza. Per questo definirei Slow Food non tanto giocando allo specchio con le Ong, quanto piuttosto pensando ad un movimento (gastronomico) globale al servizio delle innumerevoli battaglie per la difesa dei diritti delle persone e della terra che si possono ingaggiare in qualsiasi luogo e in un qualsiasi momento.

Wolf. C’era un’ambiguità di fondo nel cosiddetto movimento altermondialista che teneva insieme Ong – spesso attraversate da un certo neocolonialismo – e soggetti radicali, che oggi sembra fortunatamente dissolversi. Invece, proseguendo nell’analogia proposta da Giuliano, Slow Food in un’ambiguità simile a quella ha messo radici e prospera. Sono trent’anni che racconta con successo la sua strategiaslow, Petrini è un influencer globale, è tra i 50 salvatori del pianeta per il Guardian, è Grande Ufficiale della Repubblica Italiana eccetera; di quella strategia slow fanno parte rapporti di collaborazione con la politica istituzionale, la finanza e la Gdo (Coop e Eataly), rapporti che trovano la loro apoteosi provvisoria nella partecipazione a quella vergognosa fiera dell’ipocrisia e della mistificazione che è Expo. Ma il pianeta, proprio in questi trent’anni di successo slow, è diventato sempre più invivibile anche per quanto attiene al cibo, all’agricoltura e all’esistenza contadina. Lo stesso dicasi, se vogliamo limitarci alla scala locale, del nostro paese e dei nostri campi agricoli. E allora: se un influencer non influenza, se un riformismo non riforma, fino a quanto si è legittimati a proseguire testardamente in quella direzione? Fino a quando si è legittimati a collezionare consensi e riconoscimenti dalle stesse istituzioni che poi, nelle sedi che contano, distruggono, cementificano e intossicano? È una strategia slowo la replica infinita della stessa pièce moralista?
Giuliano. Faccio un esempio solo all’apparenza meno affine al nostro ragionamento, in parte anticipato dalle vostre prime risposte. Fino a una quindicina di anni fa chi voleva sgomberare le occupazioni diceva che i centri sociali erano covi di terroristi e/o drogati. Visto che quegli spazi si sono conquistati legittimità e hanno rotto le gabbie mentali di chi li voleva schiacciare in stereotipi, oggi giornali di destra e blogger “anti-degrado” scrivono che i centri sociali sono imprese che guadagnano a nero: il loro crimine è quello di fare “concorrenza sleale” ai poveri esercenti. Ovviamente tutto ciò è ridicolo, chiunque conosca posti del genere sa bene che si naviga nella precarietà e che non circolano affatto fiumi di quattrini esentasse. Ma è un fatto che in molti centri sociali, per restare all’esempio del cibo, ormai si mangia davvero bene per pochi euro. Forse tutto è partito dalla geniale intuizione del maestro Luigi Veronelli di portare i vignaiuoli critici dentro il Forte Prenestino e il Leoncavallo, ponendo come unica condizione che gli avventori venissero forniti di calice e non di bicchiere di plastica. Così, le trattorie popolari attingono a circuiti di consumo critico e biologico per comprare le materie prime. Anche un precario deve poter assaggiare l’hamburger di scottona e l’amarone! E può farlo proprio perché quegli spazi lavorano al di fuori del mercato, ovviamente non senza problemi, contraddizioni e sfide quotidiane. Ecco però che si propone di sgomberare le occupazioni adesso lo fa in nome della “libera concorrenza” e del rispetto delle leggi del mercato, non in nome di un principio di “legalità” astratto che non fa più presa. “Si mettano in regola, se vogliono fare commercio”, dicono i benpensanti. Arrivo alla domanda: possiamo dire che qualsiasi buona pratica per restare tale forse dovrebbe avere l’aspirazione scandalosa di combattere e restare fuori dalla dittatura del mercato? Le storie di Eataly, della degenerazione di alcune grandi centrali cooperative e delle cose “buone” che si sono messe in pancia, non dimostrano al contrario che se accetti la cornice della competizione hai perduto gran parte degli obiettivi che ti eri posto all’inizio? Ovviamente non si tratta di porre come discriminante assoluta la scelta di produrre e lavorare in stato di illegalità come sono costretti a fare gli occupanti di uno spazio, bensì di produrre nuove istituzioni e nuovi diritti. E dunque, chiedo qui soprattutto al giurista Nicola e allo studioso di memoria Wolf: il conflitto dal punto di vista della produzione agroalimentare non dovrebbe mirare a cambiare le regole e costruire spazi di autonomia del gusto dal turbocapitalismo e dal tritacarne del mercato?

Wolf. Quel conflitto deve ripartire dai bisogni, e non dalle regole: bisogno di cibo sano, bisogno di abitare, bisogno di reddito. Bisogno di aria respirabile. Una lotta per cambiare le regole, oggi, è probabilmente prematura o terribilmente tardiva, perché il capitale si sta muovendo con spregiudicatezza in un terreno che comprende tanto la norma quanto l’illegalità. Usa la legge quando si tratta di sgomberare occupazioni o manganellare facchini in sciopero, usa l’illegalità quando si tratta di aprire Eataly prima di avere i permessi. E rimescola le carte tra legale e illegale quando trasforma in norma (il Jobs Act) quella precarietà assoluta che una legge precedente, lo Statuto dei lavoratori, scongiurava. Oppure quando non rispetta l’esito di un referendum popolare, come nel caso dell’acqua. Insomma: oggi il problema è interamente quello dei rapporti di forza sottostanti la legge. I nostri “spazi di autonomia del gusto” sono quelli – tra pragmatismo e intransigenza – che il tentativo di cambiare a nostro favore quei rapporti di forza ci consente giorno dopo giorno, volta per volta.
 Nicola. Se pensiamo per un attimo alla partecipazione politica e all’esercizio del diritto di voto credo che saremo del tutto d’accordo nel riconoscere piena legittimità a quelle posizioni ideologiche che contestano radicalmente la democrazia parlamentare e non attribuiscono alcun valore alla rappresentanza, sebbene mi sembri che oggi tali opzioni debbano considerarsi velleitarie almeno quanto velleitario possa apparire lo sforzo di chi cerca di riformare il sistema. Se ora torniamo al cibo, al mercato e alla possibilità di costruire nuove istituzioni e nuovi diritti, pur guardando con la massima simpatia alle esperienze delle trattorie popolari dei centri sociali non credo che sia da qui – o soltanto da qui – che possa partire questo processo. Così come non credo che sia del tutto corretto sovrapporre la nozione di mercato con il mercato libero, il progetto neo-liberista e le strategie delle multinazionali: un contadino africano della valle del fiume Senegal ha il problema quotidiano di accedere al mercato col suo riso per poter sfamare la famiglia, ha il problema quotidiano di creare valore aggiunto sul suo prodotto di qualità per poter ripagare tutti i costi sostenuti per la campagna, mangiare e infine avviare la successiva.
Nicola. Se pensiamo per un attimo alla partecipazione politica e all’esercizio del diritto di voto credo che saremo del tutto d’accordo nel riconoscere piena legittimità a quelle posizioni ideologiche che contestano radicalmente la democrazia parlamentare e non attribuiscono alcun valore alla rappresentanza, sebbene mi sembri che oggi tali opzioni debbano considerarsi velleitarie almeno quanto velleitario possa apparire lo sforzo di chi cerca di riformare il sistema. Se ora torniamo al cibo, al mercato e alla possibilità di costruire nuove istituzioni e nuovi diritti, pur guardando con la massima simpatia alle esperienze delle trattorie popolari dei centri sociali non credo che sia da qui – o soltanto da qui – che possa partire questo processo. Così come non credo che sia del tutto corretto sovrapporre la nozione di mercato con il mercato libero, il progetto neo-liberista e le strategie delle multinazionali: un contadino africano della valle del fiume Senegal ha il problema quotidiano di accedere al mercato col suo riso per poter sfamare la famiglia, ha il problema quotidiano di creare valore aggiunto sul suo prodotto di qualità per poter ripagare tutti i costi sostenuti per la campagna, mangiare e infine avviare la successiva.
Continuo a pensare che il diritto – come scriveva Gramsci, tanto caro a Wolf – rappresenti la cristallizzazione dei rapporti di forza che agiscono in una data società in un certo momento storico. Se vogliamo rassicurarci pensando che l’osteria del centro sociale possa stare nel conflitto con le dieci multinazionali dell’agroalimentare che detengono il potere sul nostro cibo, possiamo anche raccontarcelo. Per me vanno benissimo tutte le esperienze che abitano il radicalismo alimentare (e non solo alimentare). Ma, da un punto di vista politico, a me pare molto più significativo che Carlo Petrini il 7 febbraio abbia affermato al cospetto di Renzi, Martina e Da Silva, in occasione del cosiddetto Expo delle Idee, che il problema vero del sistema agroalimentare oggi si chiama “libero mercato”, quel tipo di mercato che sta procurando danni in tutto il mondo. Sempre Petrini ha ricordato in quella occasione ai suoi interlocutori che è indispensabile una qualche forma di protezionismo alimentare se vogliamo che i contadini senegalesi non subiscano più la fame per colpa del riso orientale che arriva in Senegal a prezzi stracciati o che i contadini ghanesi non debbano ridursi a fare gli schiavi nei nostri campi per colpa dell’invasione di pomodori in scatola venduti sottocosto da ditte italiane.
Ecco, qui siamo nel conflitto. In quello vero. Dove contano i rapporti di forza. E Slow Food, essendo un movimento relativamente piccolo, gioca le sue armi come può: forse in alcuni casi in modo velleitario, forse in altri contraddittorio, ma in altri ancora nel modo più efficace possibile.
Giuliano. A me pare che Nicola descriva il ruolo di Slow Food come soggetto a sé stante, mentre Wolf ritenga che parlare di consumo, produzione e cibo significhi entrare in relazione con questioni politiche più complessive. Ecco: senza conflitti o scontri, anche su dimensione macro, come si danno i rapporti di forza necessari a cambiare la situazione?
Nicola. In realtà non credo che Slow Food sia un soggetto a sé stante, forse è un soggetto non completamente catalogabile negli schemi classici: partito, movimento, associazione. Slow Food non è un soggetto politico nel senso tradizionale del termine, non è un’associazione di categoria, non è un sindacato dei consumatori, non è un laboratorio sociale, ma forse un po’ di tutte queste cose insieme e altre ancora. In un interessante documento elaborato nell’ambito di un master dell’Unisg e pubblicato nel 2010 con il titolo Politiche alimentari e sostenibilità si affronta in maniera molto chiara questa passaggio “L’idea che occuparsi di cibo significhi in ultima analisi occuparsi di politica ha iniziato il suo cammino nella nostra realtà associativa parecchio tempo fa, forse in modo inconsapevole sin dal momento in cui i fondatori di Slow Food hanno pensato che non era sufficiente che le attività a cui si dedicavano restassero patrimonio di un gruppo di persone unite dalle stesse passioni: quelle attività dovevano diventare azione creatrice di un tessuto sociale, civile … occorre iniziare a ragionare di cibo in quanto cuore di tutte le attività umane: occorre pensare al cibo come al centro delle politiche ambientali, sanitarie, educative, economiche, sociali, culturali, legislative, produttive”. Quanto al resto della tua domanda, io penso che il conflitto sia molto importante, che alcune cose si conquistino e si difendano con il conflitto, ma penso anche che non tutto passa (può passare, deve passare) attraverso il conflitto: le buone idee camminano, le proposte valide possono trovare delle sponde, le piccole comunità sperimentano e realizzano pratiche innovative, gli esempi virtuosi generano energie, le campagne educative sulla sostenibilità producono frutti.
I rapporti di forza si misurano con il conflitto ma non cambiano (solo) attraverso di esso.

Wolf: Ancora una volta mi appello a Marx e alla sua intuizione che l’educazione, se vuole essere davvero elemento di trasformazione, deve collocarsi in una pratica rivoluzionaria – e dunque di conflitto. Quando Marx lo scrive sta pensando a Ludwig Feuerbach, ma a me sembra quasi parlare di consumo critico, di energia verde, di commercio equo eccetera, insomma di tutte quelle istanze esemplari ed educative che, quando non si ancorano a un progetto di trasformazione radicale, sono condannate all’impotenza e all’inconsistenza. Sono stato bambino negli anni settanta, è da allora che siamo bombardati da messaggi ecologisti fin dai banchi di scuola, dalla televisione: tutto questo ha forse anche solo rallentato la distruzione ambientale? Suppongo che anche i tanti piccoli Renzi abbiano visto Barbapapà come me, eppure sono grandi sponsor di ogni opera devastante per il territorio e la società – purché porti profitto. No: l’educazione senza conflitto diretto ed esplicito contro il capitale non è trasformativa. Tantomeno lo è il moralismo sfoderato da Petrini al cospetto dei potenti. Lo dico senza divertimento, lo dico con la consapevolezza che ogni altra affermazione – del tono di quelle di Nicola – è più ascoltabile, più accettabile, più tollerabile e anche più tollerante. Ma sento di doverlo dire. Il capitale da sé non si dà un confine, un limite: quel confine dobbiamo erigerlo noi. O, peggio ancora, dobbiamoesserlo noi.
Giuliano. Una narrazione, tossica ancor più di altre perché insidiosa, ha favorito l’uso distorto di un certo immaginario a scopo puramente speculativo quando non propriamente reazionario. Sia Richard Sennett nel suo noto saggio sull’artigiano che Kelefa Sanneh in un lungo e affilato articolo di critica ala saggistica “slow” statunitense apparso sul New Yorker nel 2009 citano il caso dell’intellettuale vittoriano John Ruskin, il quale era speranzoso che i fasti della architettura veneziana potessero ispirare i lavoratori nella resistenza contro “il dominio meccanico”. Si trattava di una prospettiva che non possiamo non definire conservatrice: i lavoratori avrebbero dovuto cercare l’appagamento attraverso la condotta personale e non con la battaglia politica. In “The seven lamps of architecture”, che venne pubblicato proprio all’indomani dei moti del ’48, Ruskin propose il recupero dell’artigianato come antidoto al fervore rivoluzionario. La linea antimodernista che porta questa tendenza ad invocare la libertà non dalla fatica ma attraverso la fatica finisce per dar linfa a quelli che vorrebbero trasformare l’Italia in un parco tematico composto da operosi artigiani che mettono in scena la loro vita genuina? Mi spiego meglio: il lavoro manuale indipendente e di piccola filiera non contiene di per sé prospettive radiose. A me pare che la trasposizione di questa etica individuale nella società dei consumi produca una superficiale “etica del consumo” in base alla quale basterebbe comprare in maniera informata e cosciente o diventare dei perfezionisti della raccolta differenziata nei salotti di casa nostra, per risolvere dall’interno e in nome di uno dei pilastri dell’utopia liberista (la circolazione delle informazioni e l’uguaglianza degli attori) alcune distorsioni. In altre parole: dire che agendo “da consumatori” possiamo cambiare lo stato di cose presenti non significa in fondo aderire alla dittatura del libero mercato, in base alla quale la concorrenza premia sempre il migliore, quindi anche il più buono? La rivoluzione, come è noto, non sarà teletrasmessa. Ma credo possiamo dire che non sarà neanche venduta in un qualche tipo di negozio.
Wolf. Oggi, dopo sconfitte storiche clamorose, è come se fossimo in un lunghissimo post-48. Se respingiamo Ruskin non ci viene in aiuto neppure il già citato Feuerbach, che nel 1850 conia il famoso “l’uomo è ciò che mangia” e la contestuale proposta di una dieta di lenticchie per restituire al popolo tedesco la forza di fare la rivoluzione. Però Feuerbach amava i paradossi e, con tutti i limiti del suo materialismo acerbo, nella rivoluzione sociale ci credeva davvero. Invece, chi oggi ne cita la frase, come fanno tra i tanti Carlin Petrini e Andrea Segrè, vuole suggerire che cambiando alimentazione, “consumando eticamente” si può cambiare il mondo. Così, mentre il consumatore si rode nei sensi di colpa per la sua esistenza mai abbastanza etica, il capitale riscrive i percorsi della produzione e del consumo alimentare a sua immagine e somiglianza travolgendo ogni ostacolo sociale e naturale. Compresa la biologia, che viene piegata al profitto tramite le tecnologie genetiche e la proprietà dei semi. Nell’idea che il mercato premi i migliori, e quindi eventualmente anche i più buoni, quegli intellettuali della sinistra Slow si dimostrano seguaci di un liberismo fantasioso e moralista. Secondo il quale la “mano invisibile”, se guidata dall’etica e non dall’egoismo, garantirà il benessere sociale e ambientale. Ma se già quella dei “vizi privati” che diventano “pubbliche virtù” era una storiella incredibile, questa delle virtù private che salvano il mondo, proprio mentre il capitale lo rende invivibile, non è buona neppure per uno spot del Mulino Bianco.
Nicola. Tutta la diffidenza possibile nei confronti della Gdo non può certo farci rimpiangere i pizzicagnoli di un tempo (“Banchieri, pizzicagnoli, notai / coi ventri obesi e le mani sudate / coi cuori a forma di salvadanai” cantava non a caso De Andrè). Per restare in tema di citazioni musicali, se a canzoni non si fan rivoluzioni è certamente vero che nemmeno riempiendo i carrelli della spesa faremo rivoluzioni. Su questo ha ragione Wolf: c’è certamente una retorica eccessiva nei propagandisti (tra cui mi ci metto volentieri) del consumo critico, ma non mi pare particolarmente utile eccedere nell’esagerazione opposta, estremizzando la critica del consumo critico.
Nel mercato, e soprattutto nel mercato del cibo, ci stiamo tutti nostro malgrado, e se non possiamo cambiare il mondo scegliendo questo o quel prodotto certamente possiamo ottenere dei risultati attraverso le scelte e l’impegno. Gli esempi potrebbero essere centinaia: nella sola Calabria stiamo lavorando ad un progetto per l’attribuzione gratuita di terre demaniali a giovani e migranti, sosteniamo le esperienze delle cooperative che gestiscono i terreni confiscati alle mafie, distilliamo la birra artigianale insieme ai bambini di una casa di accoglienza per le vittime di abusi sessuali, impastiamo il pane che viene dai grani antichi recuperati da piccolissimi produttori e via dicendo: salviamo un po’ di paesaggio e le nostre intelligenze, se proprio non possiamo salvare il mondo.
Piccole cose, certo, che forse suoneranno un po’ retoriche a raccontarle tutte insieme, ma che spostano quelle piccole cose che sono le vite di alcuni in un pianeta abitato da miliardi di persone. Comunque un modo utile (il più utile?) di accompagnare la battaglia globale per il cambiamento di questo sistema agroalimentare, perché la critica è sempre utile – forse indispensabile per evitare che si costruiscano posizione di potere carismatico eccessive – ma sarebbe bene non sbagliare del tutto i nemici, e non dimenticare che la vera posta in gioco è contrastare la colonizzazione totale dell’immaginario collettivo e la trasformazione completa del cibo in una merce.
Il cibo deve essere un bene comune, accessibile a tutti. Da qui ripartiamo.
Giuliano. Mentre questa nostra discussione prendeva corpo, è venuta fuori la notizia che comprare da Eataly costa di più che rivolgersi ad un normale supermercato. Pochi giorni fa un piccolo produttore di liquori mi diceva che avrebbe la possibilità di entrare nella filiera di Farinetti, solo che farlo gli costerebbe più di quanto già gli costa avere a che fare con una catena tradizionale della grande distribuzione organizzata. Fatta chiarezza sulla necessità di evitare ogni rimpianto di (inesistenti peraltro) bei tempi andati e detto altrettanto nettamente che il consumo da solo non basta a cambiare il mondo, ci date due dritte su come scegliere i posti in cui andare a far la spesa?
Nicola. Un solo consiglio: se e quando possibile comprare direttamente dal produttore. Anzi, scegliere con cura il produttore a cui rivolgersi: perché l’obiettivo principale deve essere quello di accorciare la filiera, ma evidentemente non tutto ciò che è diretto è anche buono, pulito e giusto.
Wolf: Non me la sento di dare dritte, posso solo dirti dove faccio la spesa io. Quando posso dai produttori con cui ho anche un’affinità politica, come quelli di Genuino Clandestino, quando posso un po’ meno da produttori qualsiasi purché almeno locali, ma poi anche al supermercato – quando la frenesia di una vita quasi impossibile mi stringe le mani intorno al collo. E non mi faccio problemi a dire che questo accade molto spesso. E se questo mi capita – se questo capita a tanti, quasi a tutti – è in buona parte perché, proprio mentre parliamo tanto di fare la spesa, abbiamo rinunciato a parlare di quanto dobbiamo lavorare e di quanto poco guadagniamo, di dove e come abitiamo, di quanto e come siamo costretti a spostarci. Allora: riapriamo tutte le partite, perché se continuiamo a giocare solo quella del consumo siamo sconfitti.
Tag:
cibo conflitto consumo consumo critico eataly expo la danza delle mozzarelle nicola fiorita riformismo slow food wolf bukowsi Wu Ming


![[DallaRete] Il cibo, il consumo, il conflitto. Dialogo tra Wolf Bukowski e Nicola Fiorita su #Slowfood, #Eataly ed #Expo2015](https://milanoinmovimento.com/wp-content/uploads/2015/06/nicola_wolf.jpg)
