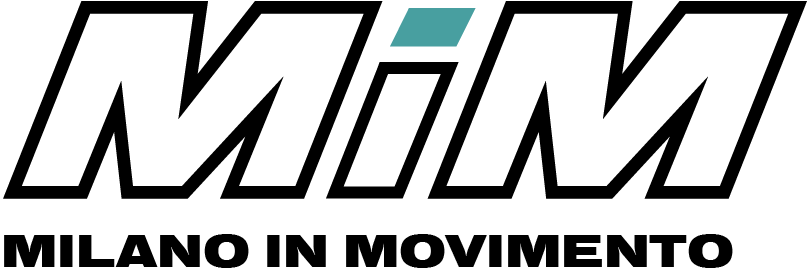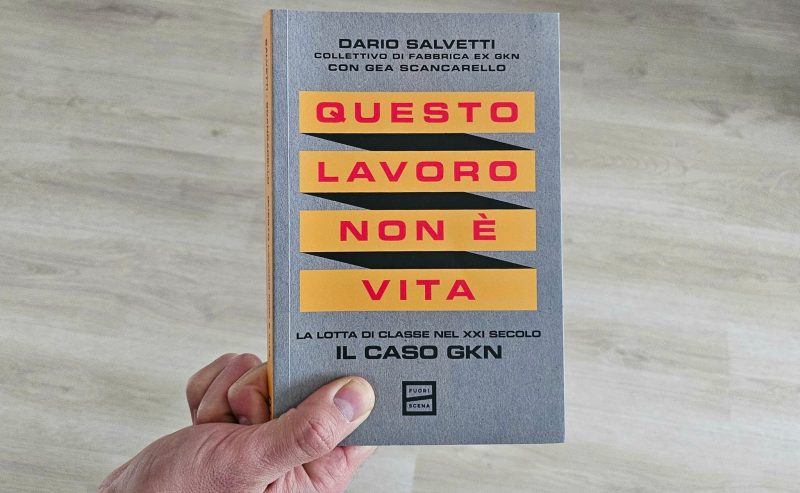Gkn, una storia di lotta di classe nel XXI secolo
Spesso in questi anni ci è capitato di scrivere della straordinaria esperienza della Gkn la cui diversità da altre vertenze, per chi mastica un po’ di politica e sindacato, era immediatamente e plasticamente riscontrabile già dalla firma utilizzata da lavoratrici e lavoratori: “Collettivo di Fabbrica”, una firma antica, ma moderna che raccontava molto di quella cosa antica, ma moderna che era “l’autonomia operaia” (con la a minuscola). Scriviamo quindi con piacere del libro Questo lavoro non è vita di Dario Salvetti con Gea Scancarello di cui riportiamo qui l’introduzione. Per chi ha esperienza di lotte sindacali quest’opera è, al tempo stesso, esaltante e sconfortante. Esaltante per l’epopea operaia raccontata e per la solidarietà di popolo capace di costruire, sconfortante per il senso di solitudine che emerge dalle pagine stesse, una solitudine determinata dalla totale assenza della politica, ma spesso e volentieri anche delle strutture sindacali abituate come sono da decenni a “portare a casa il compitino” di pura testimonianza senza infamia e senza lode e che spesso vivono il protagonismo dei lavoratori più come un problema che come una risorsa. Un libro capace di toccare ogni singolo punto nevralgico del disastro sociale prodotto dal neoliberismo imperante, ma dal quale emerge la forte la sensazione che il mondo, comunque, fino a quando non si sarà capaci di ridare alla cose il loro nome in un discorso egemonico come gli operai della Gkn stanno tentando di fare, continuerà imperterrito ad andare da un’altra parte. Del resto come diceva la celebre frase? “Socialismo o barbarie”. Ecco. Appunto.
Si dice spesso che il primo modo per risolvere un problema sia quello di dargli un nome.
Quando si tratta di lavoro e di diritti, chiamare le cose con il loro nome però non è più così semplice: la chiarezza è stata erosa dalla trasformazione del senso comune prodotta da decenni di smantellamento della coscienza di classe. Un’imponente macchina ideologica è costantemente in funzione per normalizzare certe ingiustizie, annacquando la possibilità di combatterle. Il linguaggio è lo strumento privilegiato di questo processo: quando il racconto dei fatti è farcito di elementi tecnici e specialistici, l’essenza finisce sullo sfondo. La “delocalizzazione” diventa così una risorsa dell’industria come altre, legata a “margini in calo” e alla necessità di “valorizzare il ritorno degli investimenti” per evitare la “caduta del valore e la possibile fuga degli azionisti”, e via discorrendo. L’infilata economicista nasconde una verità: l’azienda se ne va da qualche altra parte, dove i lavoratori vengono pagati meno o le tasse sono più basse, perché l’obiettivo del capitalista non è solo far soldi bensì farne sempre di più. Anche se significa lasciare decine, centinaia o migliaia di persone senza il denaro per mangiare, curarsi e mandare a scuola i figli. Anche se significa togliere loro la dignità nonché dimostrare che lo Stato, cioè l’organizzazione che dovrebbe avere come primo interesse la comunità di cittadini che aggrega, ha meno potere, e certamente meno volontà, dl capitale che muove fabbriche e contratti.
Nonostante i tentativi di resistenza a questa logica con decenni di logiche operaie e di popolo, brevi e lunghe, in tempi recenti la società ha apparentemente assorbito questa realtà come incontrovertibile e imbattibile. Quando si leggono le “richieste” delle grandi aziende ai vari ministri – cassa integrazione, bonus, prestiti, normative agevolate – pochi si chiedono perché: perché può essere solo l’azienda a domandare, cioè spesso a pretendere; perché l’informazione viene comunicata dai media senza una riflessione sulla legittimità della richiesta; perché infine, abbiamo trangugiato come prioritario il punto di vista dell’azienda e mai quello del lavoratore, che è in realtà il motore della produzione e della creazione di valore, in qualsiasi campo.
A scardinare questa rassegnazione, ribaltando la prospettiva, negli ultimi anni è stata una lotta straordinaria, intesa letteralmente come fuori dall’ordinario: quella del Collettivo di fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), delle operaie e degli operai di quella fabbrica, delle loro rappresentanze sindacali e di un territorio solidale insorto con loro.
Licenziati da un giorno all’altro con una email (i giornali diranno WhatsApp, come se servisse un elemento ulteriore di spettacolarizzazione), i lavoratori dello stabilimento che produceva semiassi per l’industria automobilistica hanno deciso di combattere la decisione con ogni strumento a loro disposizione, al posto di accettarla passivamente. Ricevendo, peraltro, un plauso unanime dalle istituzioni, cui ha fatto seguito un altrettanto unanime, e prolungato, disinteresse effettivo. In più di tre anni di battaglia per riavere i loro posti di lavoro, gli ex Gkn riuniti nel Collettivo di fabbrica, nelle proprie organizzazioni sindacali, in assemblea permanente e infine in una Società operaia di Mutuo soccorso sono stati in grado di rimettere al centro dell’attenzione l’essenza così abilmente occultata nel dibattito pubblico: la prepotenza di un capitalismo sempre più selvaggio e allergico a qualsiasi regola, persino autoimposta; le conseguenze sulla vita delle persone, anche in termini di salute; il modo stesso di intendere il lavoro, mattone fondativo del Paese, secondo la Costituzione, me nella realtà sempre più lontano da come viene definito ampiamente in quelle pagine tanto celebrate quanto disattese. (…)
La lotta degli operai della ex Gkn, condotta con creatività e resistenza pacifiche, ha risvegliato in molti quel senso di giustizia soffocato dal fatalismo rassegnato, portando a galla questioni esistenziali che non riguardano soltanto i 422 licenziati ex abrupto, ma l’intera collettività.
Che si tratti di un negozio, di una fabbrica, di un’agenzia di viaggi o di comunicazione, di un pezzo dell’industria mediatica-culturale o persino dello Stato nei suoi mille impieghi, non c’è quasi persona che non si sia trovata a lavorare in condizioni irregolari, con contratti che non corrispondono alle reali mansioni o al tempo dedicato, oppure sottopagata, senza possibilità di mettere in discussione scelte sbagliate e ingiuste che non abbia subito ricatti più o meno aperti. (…)
La volontà di non capitolare di fronte all’abuso e alla presunta assenza di alternative ha aperto gli occhi sugli abusi che tutte e tutti, ognuno a proprio modo, subiscono, e sull’atomizzazione dell’azione che è ricetta per la sconfitta del gruppo. (…)
P.S. Notevole in appendice la presenza del famigerato discorso tenuto da Mario Draghi sullo yacht Britannia il 2 giugno 1992 da molti visto come snodo epocale della svendita del patrimonio produttivo italiano ai privati e distruzione di qualsiasi programmazione industriale da parte dello Stato
P.S.2 Il 5 marzo a Torino si terrò la presentazione del libro con la presenza di Alessandro Barbero.
Tag:
atomizzazione capitalismo collettività collettivo di fabbrica delocalizzazione fabbrica gkn lavoratori libro lotta mobilitazione neoliberismo operai resistenza salvetti sindacati vertenza